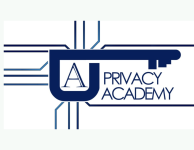I VANTAGGI DELL'ESSERE SOCI
- 1 webinar in streaming al mese sulle novità della Data Protection e della Digital Law;
- 3 eventi fisici l’anno in località bellissime a prezzi speciali, con attestato di frequenza delle ore svolte;
- Tante registrazioni accessibili On Line;
- Sconti sul corso avanzato per Dpo da 120 ore;
Sconti su eventi collegati, patrocinati da Privacy Academy o dove sono presenti relatori della stessa;
- Accountability dimostrata sia per Dpo Che per Aziende, essendo Privacy Academy tra le prime Associazioni sul tema Data Protection che ha avuto il patrocinio del Garante per il suo Corso Avanzato per DPO;
- Network di esperti Dpo e Digital Law.